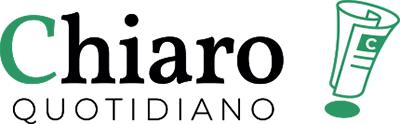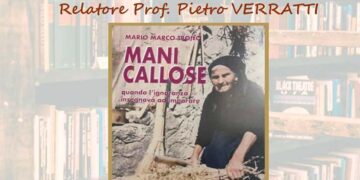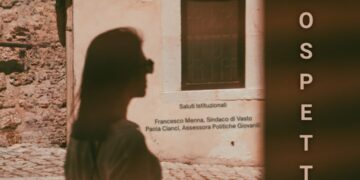Da giovedì 8 fino a domenica 10 dicembre il quartiere Civitanova si animerà grazie all’evento Natale in Musica..Nova. Ma oltre all’immancabile atmosfera natalizia ci sarà anche spazio per la cultura con l’apertura serale e straordinaria del Museo Diocesano che nel fine settimana spalancherà le sue porte nelle ore serali che vanno dalle 19 alle 22. Ma tra le possenti mura del Palazzo Arcivescovile oltre a visitare le mirabili opere d’arte che ne arricchiscono le sale sarà possibile ammirare, solo per tre giorni, anche alcune preziose ceramiche e maioliche antiche che coprono un arco cronologico che va dal ‘500 al ‘900 e che provengono da alcune importanti collezioni private. L’esposizione, curata dal critico e storico dell’arte frentano Franco Maria Battistella ha come riferimento iconografico la Vergine Maria, una scelta questa casuale ma decisa per celebrare al meglio l’8 dicembre, giorno in cui la Chiesa festeggia l’Immacolata Concezione.
A Chiaro Quotidiano la dottoressa Ada Giarrocco, responsabile dei Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Lanciano – Ortona ha illustrato nel dettaglio la storia e lo stile degli esemplari presenti in mostra «Questa esposizione comprende maioliche che vanno dal tardo ‘500 agli inizi del 1900 realizzate dai più grandi ceramisti abruzzesi – afferma la Giarrocco – con alcune eccezioni e ceramiche che invece arrivano da Bassano Romano, Faenza ed Urbania. I maestri che li hanno realizzati portano i nomi di Carmine Gentili (1678-1763), Liborio Grue (1702-1776) e Fedele Cappelletti (1847-1920)». Di particolare interesse sono le ciotole lauretane considerate taumaturgiche poiché oltre all’argilla erano impastate anche con la polvere proveniente dalla Santa Casa di Loreto. Questi manufatti erano singolari perché avevano anche una funzione apotropaica in quanto erano utilizzati per dare da mangiare ai malati e agli infermi.

«Estremamente interessante – sottolinea Ada Giarrocco – è una ciotola che raffigura la Madonna del Bagno di Deruta, paese della provincia di Perugia, legato ad una leggenda che è all’origine di questa particolare e sentita devozione». Il fatto accade intorno alla metà del XVII secolo, quando un frate zoccolante cappuccino mentre transita su un sentiero che costeggiava la vecchia arteria romana scorge tra i sassi e l’erba i resti di una tazza per bere. Sul fondo interno di questa campeggiava una piccola immagine della Madonna col Bambino dall’iconografia insolita e non convenzionale: il Bambino è in grembo alla Madre, non seduto ma quasi genuflesso sul ginocchio sinistro, in posizione scattante e quasi insofferente della postura tenuta fin lì, come di chi si appresta ad accorrere in aiuto di qualcuno che invoca soccorso da lui e di cui lui solo sembra udire la voce.
La sua mano destra sostiene una sfera, il mondo, dove vivono gli uomini per i quali è venuto, i suoi fratelli che è venuto a salvare. Alla Madre, che sembra osservarlo stupita, egli indica con la mano sinistra l’oggetto e la ragione della sua urgenza: il mondo che solo lui può salvare perché quel mondo è suo, perché Lui l’ha creato, perché Lui l’ha redento, perché solo da Lui può giungere ad esso il perdono. E con il perdono la speranza. Il devoto fraticello non vuole quindi che la piccola tazza con la sacra immagine resti in terra, esposta al rischio d’essere calpestata e la depone allora su una giovane quercia prima di riprendere la sua strada. La piccola tazza, sistemata in maniera precaria cade nuovamente a terra, finché un giorno un mercante di nome Christofono, la trova e la fissa solidamente alla quercia. Secondo la leggenda avvenne poi che nel marzo del 1657 la moglie di Christofono, si ammalò gravemente fino a ridursi in fin di vita. Il pover’uomo, giunto davanti alla quercia e all’immagine di Maria che lui stesso aveva fissato all’albero, levò alla Madre di Dio una preghiera per la guarigione della moglie. Alla sera, tornato a casa dalla fiera, la trovò perfettamente guarita e intenta ai lavori domestici.

La notizia del miracolo si diffuse in un baleno ed incominciò subito il pellegrinaggio alla Quercia del Bagno: presto una piccolissima cappella fu costruita per racchiudere la quercia e l’immagine, tanto che l’autorità ecclesiastica si trovò costretta a interdire l’accesso alla stessa. Un mese dopo il culto alla Madonna della Quercia fu approvato, e il 28 ottobre dello stesso anno, a cappella non ancora terminata, ci fu una grande festa con la partecipazione di fedeli che segnò l’inizio ufficiale del culto. La cappellina si dimostrò subito insufficiente e nel 1687 venne edificata una nuova chiesetta più grande, corrispondente a quella che esiste tutt’oggi a Deruta.
«Altri elementi della mostra di grande pregio – conclude la dottoressa Giarrocco – sono una piccola statua della Concezione di Castelli del 1620, un albarello con la Madonna col Bambino di Castelli di fine XVI secolo, un portachicchera di Castelli con l‘Adorazione dei Magi, tre mattonelle con l’Immacolata di Castelli, un’acquasantiera domestica di Castelli con l’Immacolata, due mattonelle di Castelli con la Sacra Famiglia ed un ovale di Castelli con la Madonna Gesù Bambino e San Giovannino. Non appartenenti a delle feste liturgiche di dicembre e gennaio, sono infine una mattonella di Castelli con l’Addolorata e le anime purganti, del XVIII secolo e una con la Sacra Famiglia, maiolica storicista nello stile castellano dipinta a Rapino da Fedele Cappelletti». Una piccola, ma imperdibile esposizione che ci porta alla scoperta di forme di arte, devozione e fede oggi scomparse.